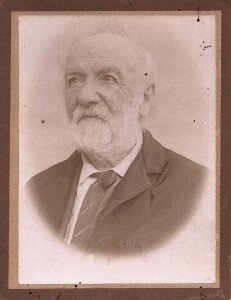Vite e vino nella Sicilia
Nel corso del XIX secolo la viticoltura e l’enologia siciliana sono state oggetto di profonde trasformazioni, conseguenti al simultaneo sviluppo di eventi e processi del tutto nuovi rispetto a quelli maturati con molta gradualità nei secoli precedenti. A voler cogliere in estrema sintesi quelli più rilevanti, si devono evidenziare almeno i seguenti:
- Lʼespansione della vite, come si dirà più avanti, assunse un carattere tale da consentirle il sorpasso su qualunque altra coltura e di attestarsi al secondo posto ‒ dopo i cereali ‒ per superficie dedicata.
- Il perfezionamento degli studi di ampelografia, stimolati in modo significativo dagli scritti di eminenti autori francesi, diede impulso alla formazione in tutto il Paese di collezioni viticole, ad opera di proprietari sia aristocratici che borghesi, sempre più interessati a comprendere le differenze tipologiche tra le diverse varietà di viti sia indigene che importate da altre regioni o stati esteri. Ciò, ovviamente, non era finalizzato solo a sviluppare le conoscenze agronomiche specifiche, ma anche a valutare le rispettive potenzialità sul piano dei risultati enologici.
- La nascita di un vino nuovo, il marsala ad opera dei mercanti-imprenditori britannici già presenti nellʼIsola dalla fine del Settecento; un vino “conciato”, cioè alcolicamente potenziato in cantina. Il marsala non era il primogenito della categoria dei vini liquorosi “creatiˮ dagli inglesi; il porto, il madeira, il malaga, lo sherry erano già disponibili da decenni nel mercato britannico, tutti accomunati dalla maggiore robustezza perché rinforzati con acquavite di vino.
- La nascita dei primi vini da tavola, a partire da metà Ottocento, nel tentativo di emulare i più rinomati di Francia, assecondando un nuovo orientamento di consumo e associando il prodotto a una diversa modalità di considerare “il bere” come parte integrante dello stile di vita non più solo aristocratico ma borghese.
- La proliferazione di riviste e periodici specializzati in tutte le province dalle quali si rileva una notevole capacità di analisi dei problemi del settore e una forte tensione allʼammodernamento dei criteri colturali e di vinificazione.
- La separazione netta tra le competenze viticole e quelle enologiche, tra il mondo dei vignaioli e quello degli imprenditori vinicoli che si registrerà ‒ prima che in ogni altra regione italiana ‒ proprio a partire dalla provincia di Trapani, dove i mercanti britannici costituiranno l’avanguardia degli industriali del vino.
- Non ultima, la diffusione di gravi malattie della vite, dallʼoidio alla peronospora e, soprattutto, alla fillossera, che comporterà l’avvio della sperimentazione della Vitis rupestris americana come porta innesto per salvare la Vitis vinifera europea.
Questi, dunque, alcuni dei dati di fatto che ci portano a considerare lʼOttocento come il secolo della svolta epocale per la viticoltura.
In Sicilia, nel 1853, a conclusione dei lavori per la compilazione del catasto borbonico, l’estensione complessiva del vigneto veniva calcolata intorno a 145 mila ettari, sui quali si stimavano circa 744 milioni di viti. Trent’anni dopo, in occasione dell’Inchiesta agraria parlamentare, negli atti relativi alla Sicilia, pubblicati nel 1884, la superficie destinata a quella coltura risultava più che raddoppiata, quasi 322 mila ettari. Mediamente, quindi, in quel trentennio, vennero destinati a vigneto, ogni anno, 5.900 ettari di terre, estirpando soprattutto decine di migliaia di ulivi. Sulla spinta, infatti, di sollecitazioni economico-commerciali, a partire da una certa data, lʼobiettivo quantitativo dellʼincremento della produzione enologica, andò inevitabilmente a detrimento della qualità; la crescita tumultuosa condizionava la selezione delle varietà viticole e contribuiva a mantenere i criteri di vinificazione a un livello primitivo.
All’interno di una logica così poco lungimirante, il viticoltore imboccava la scorciatoia: aumentare la resa di uve da vino, scegliendo le varietà in grado di assicurare maggiore succosità e grado alcolico. La forte dipendenza della produzione isolana dall’andamento della domanda estera e continentale di vini da taglio si rafforzò a metà degli anni Settanta dell’800, in conseguenza del crollo della viticoltura francese che era stata colpita dalla Phylloxera vastatrix, che non si era ancora propagata nella nostra penisola.
Nel decennio 1871-1880 il vino siciliano esportato all’estero passava da circa 100 mila ettolitri lʼanno a più di 760 mila. Le enormi quantità di vino esportate, per esempio, da Giarre-Riposto non potevano ritenersi pregiate; era vino dozzinale ma resistente, la cui commercializzazione costituiva la maggior parte della ricchezza del territorio di Mascali. Lo notava chiaramente nel 1878, il presidente della Commissione ampelografica della provincia di Catania, Michele Turrisi Scammacca: «alcune uve senza dubbio eccellenti e che un tempo erano piuttosto diffuse sono invece oggi trascurate, cedendo il posto ad altre di qualità assai più scadenti» [1].
Ancora tre anni dopo, l’agronomo professor Gregori osservava che, nonostante la coltivazione della vite in Sicilia fosse praticata con abilità e con amore, tuttavia la commistione all’interno di uno stesso vigneto di varietà completamente diverse tra loro, rappresentava un errore grave e persistente: «È imprescindibile la specializzazione dei vigneti […]. La parola illuminata del commendatore Zerilli a Milazzo e gli studi del barone Mendola di Favara, nei suoi possedimenti in provincia di Girgenti, sono troppo individuali e isolati, perché si possa sperare che i loro conterranei ne accettino e adottino sollecitamente i dettami» [2].
Si era ancora in una fase nella quale, accanto a una ristretta cerchia di viticoltori aristocratici e borghesi molto esperti e lungimiranti, continuavano a operare proprietari e mezzadri poco consapevoli dei progressi e delle conoscenze che andavano maturando nella cura del vigneto.
Uno dei contributi più originali della prima metà dell’Ottocento venne da una personalità del mondo letterario quale è stato il poeta e filologo di Acireale Leonardo Vigo, il quale intervenne sulla questione della decadenza enologica siciliana, spostando l’attenzione sulla priorità di una buona viticoltura senza la quale sarebbe stato illusorio pretendere la produzione di buoni vini: «Da Trapani a Messina a Pachino possediamo cento varietà della vitis vinifera atte a’ vini bianchi, neri, dolci, asciutti, leggieri, violetti, alcoolici, bruschi, abboccati, navigabili o no, […] e ignoriamo quali siano, ove come si coltivino, quale delle usate colture è preferibile, quali siano i cento modi come si fabbrica il vino nelle 300 comunità siciliane» [3].
Ma il contributo del barone Mendola di Favara eccelle su tutti. In particolare, con Giuseppe Antonio Ottavi, fondatore del prestigioso periodico «Il Coltivatore» che si pubblicava a Casale, avviò un’intensa collaborazione, che si tradusse, fra l’altro, nell’incarico ufficiale – conferito dal Consiglio provinciale agrigentino, proprio su proposta di Mendola – di redigere un progetto per impiantare un Istituto per il miglioramento dell’agricoltura: «Accettai l’incarico – scriveva Antonio Ottavi – e già sullo scorcio di aprile 1865 io scendeva [sic] a Porto Empedocle coll’intento di percorrere, come feci, in vario senso la Provincia. Stesi, alcune settimane dopo, una breve relazione, alla quale seguì poscia l’accennato progetto» [4] che sarebbe stato accettato dal Consiglio. I ripetuti incontri di lavoro avuti da Ottavi con Giuseppe Inzenga, a Palermo, e con Antonio Mendola e i proprietari terrieri marchese Cafisi e barone Genuardi, a Favara e Agrigento, portarono anche a un altro importante risultato: la pubblicazione di una monografia di Principii generali di agricoltura per le regioni calde con applicazioni alla provincia di Girgenti, che l’agronomo Ottavi realizzò proprio grazie ai sopralluoghi compiuti in quella provincia.
Da cosa nasceva la reciproca stima tra questi due personaggi così culturalmente e geograficamente diversi e distanti? Il Mendola aveva cominciato a creare nei suoi possedimenti una delle più grandi e importanti collezioni di viti provenienti da ogni parte del mondo, oltre che dalle diverse regioni italiane, che avrebbe raggiunto il ragguardevole numero di circa tremila varietà. Già nel 1868, Mendola aveva pubblicato un primo elenco della sua collezione riguardante circa 1200 diverse viti coltivate nei poderi di Favara, dove dedicava tempo e intelligenza a sperimentare e a studiare i risultati delle ibridazioni, cioè dell’incrocio tra soggetti della stessa specie per ottenere viti migliori.
Come ricordava il professor Salvatore Accardi, «[…] creò nuove varietà, talune delle quali pregiatissime. Al professor Cerletti dedicò il Catarratto moscato Cerletti» [5], ottenuto da seme di Catarratto bianco fecondato artificialmente con Zibibbo. Sue creature furono anche il Catarratto bianco Caruso, in onore del professor Girolamo Caruso; la Malvasia nera Rovasenda, il Mantonico nero Inzenga, il Moscato Pulliat e l’Olivetta nera Marès, in onore dei tre grandi ampelografi Giuseppe di Rovasenda, e dei francesi Victor Pulliat e Henri Marès, nonché del suo primo maestro, Giuseppe Inzenga, direttore dell’Istituto Agrario Castelnuovo di Palermo.
Il contributo dello studioso favarese si rivelò altrettanto prezioso e fondamentale nella predisposizione della documentazione ampelografica che integrava la relazione di Abele Damiani, per la parte riguardante la Sicilia, negli atti dell’inchiesta agraria pubblicati nel 1884. Il relatore parlamentare non esitava a riconoscere che, nelle province a forte connotazione viticola, «si dà molta importanza al piantamento e alla coltivazione della vigna, che del resto praticasi con metodi diversi. Quanto alla scelta dei vitigni ancora si è indietro. Spesso non viene data la preferenza ai migliori» [6]. I dati sulle varietà delle diverse province furono in maggior parte forniti dal Mendola e cioè, per ciascuna provincia, con esclusione di quella di Palermo, erano le seguenti: Caltanissetta-Enna 36; Catania 21, Girgenti 95, Messina 46, Siracusa-Ragusa 39 e Trapani 41; non considerando, quindi, i dati della provincia di Palermo, si segnalavano le denominazioni di 278 varietà! Si badi, a quella data gli effetti della fillossera nellʼIsola non si erano ancora fatti sentire.
In Italia, l’allarme era stato lanciato nel 1870 dalla «Rivista di Agricoltura, Industria e Commercio» di Firenze, con la notizia dell’avvenuta infestazione delle viti francesi e con le informazioni allora disponibili sul comportamento del parassita. A novembre dello stesso anno il medico castelbuonese Francesco Minà Palumbo mostrava di essere già ben documentato, come rivela la sua prima corrispondenza sull’argomento, inviata al direttore del bollettino del Comizio agrario di Noto. E quando ancora in Italia molti si illudevano che la fillossera non avrebbe varcato le Alpi, lui scriveva – nel 1874 – di resistenza delle viti americane e indicava una possibile soluzione al male con il quale presto o tardi ci si sarebbe dovuti confrontare.
In una lettera da Castelbuono dellʼaprile 1880, pubblicata in «L’Agricoltura Italiana», dell’Istituto agrario dell’Università di Pisa, riferiva del primo focolaio di infezione scoperto in Sicilia nel territorio di Riesi, manifestando la convinzione dell’avvenuta diffusione in altre zone non ancora individuate. Come noto, la legislazione adottata in Italia prevedeva che si procedesse tempestivamente a limitare le zone infette e a distruggere le piante colpite e buona parte di quelle prossime.
Concreto e pragmatico, Minà Palumbo proponeva di accordare premi e incoraggiare gli studi sulla biologia dell’insetto, lasciando liberi i proprietari di introdurre vitigni resistenti al parassita. Sul terreno della divulgazione si rivelò molto impegnato compilando, nel 1881, per il periodico dell’Istituto agrario pisano, una rassegna sull’argomento di 265 titoli, tra monografie e articoli di riviste, pubblicati in Italia dal 1868 al 1880.
Quando finalmente ci si rese conto dell’inutilità del sistema distruttivo regolato dalla legge e si cominciò a investire sulla creazione di piante resistenti mediante incroci tra varietà americane e indigene, Minà Palumbo diede il suo contributo pionieristico. Le sue indicazioni erano ispirate a concretezza e prudenza; ogni esperimento andava ponderato e verificato ripetutamente, nella consapevolezza che non esistesse la soluzione universale applicabile a tutti i terreni e che la compatibilità tra “piede americano” e vite locale da innestare sarebbe stata trovata solo dopo innumerevoli prove. I suoi interventi sulla stampa specializzata erano sempre improntati alla necessità di svolgere una funzione didattica nei confronti dei viticoltori che in larga parte affrontavano la ricostituzione dei propri vigneti con approssimazione e scarsa competenza, come ebbe a lamentare nelle pagine del periodico del Comizio agrario palermitano, mettendo a disposizione una selezione ragionata delle principali caratteristiche di alcune varietà americane.
Non visse tanto da assistere al pieno successo delle sue intuizioni sulla validità della tutela delle biodiversità e della sperimentazione agronomica, ma i risultati conseguiti nel primo ʼ900 si devono anche alla sua visione moderna della botanica. Una nuova generazione di viticoltori avrebbe raggiunto il traguardo.
La Società di Acclimazione di Palermo, allora presieduta dal barone Sciacca della Scala, intervenne con analoga tempestività, dando incarico a due soci docenti universitari – lo zoologo Pietro Doderlein e il chimico Emanuele Paternò – di recarsi nel territorio di Riesi per accertare direttamente la vastità dell’invasione fillosserica. I due illustri studiosi, nel corso dell’ispezione, constatarono che l’arrivo del parassita poteva farsi risalire almeno a otto anni prima della “scoperta” ufficiale e che, ciò nonostante, i vigneti avevano continuato a essere produttivi. Ne deducevano non soltanto che la fillossera aveva mostrato di progredire con relativa lentezza rispetto ad altre zone d’Italia, ma anche che la distruzione dei vigneti prevista dalla legge avrebbe dovuto contemplare un’entità di risarcimento ai proprietari corrispondente al valore dei raccolti stimabili, caso per caso, almeno da uno a quattro annate di produzione. La distruzione immediata dei vigneti infetti e di quelli limitrofi apparentemente integri, comportava perdite effettive maggiori di quelle che si sarebbero prodotte non intervenendo affatto.
La sottolineatura del tema dei risarcimenti centrava in pieno uno dei nodi sociali della questione che la propagazione della fillossera stava generando: come era pensabile sviluppare unʼefficace campagna di sensibilizzazione e di prevenzione senza la convinta e generale collaborazione dei diretti interessati?
La distruzione dei vigneti disposta e praticata nel corso del 1880 – che prevedeva la recisione delle viti a 20-30 cm. dal suolo – nelle due province di Caltanissetta e di Messina, riguardò circa 51 ettari di vigneto, 17 dei quali nella zona di sicurezza, cioè di piante ancora integre, ma contigue a quelle infette. Le parti così recise venivano bruciate e i monconi imbiancati con latte di calce; si procedeva poi a irrorare le radici con il solfuro di carbonio (nocivo alla salute degli operatori, ma la sensibilità su questo aspetto era allora quasi inesistente), circa 40 grammi di insetticida per ognuno dei 5 fori praticati attorno a ciascuna pianta che, subito dopo, venivano richiusi per evitare dispersione dei vapori. Purtroppo questi interventi si rivelarono non solo inefficaci ad arrestare la propagazione del parassita ma anche molto costosi.
Nel 1882, Antonio Mendola, sollecitato a fornire un parere sulla validità dell’utilizzo delle viti americane, non esitava a dichiarare come l’unico modo di premunirsi contro la fillossera fosse proprio quello di confidare «nellʼimpianto di vigneti a viti americane resistenti». In particolare, consigliava «[…] come porta innesti resistentissimi la Vitis Solonis ed il York Madeira. Li coltivo da anni e prosperano egregiamente in Sicilia; […] Il Solonis è infruttifero – poco frutta il York Madeira – bisogna innestarli colle nostre viti. Da ciò nasce il ceppo bimembre cioè colla radice americana resistente e colla chioma europea fruttificante» [7]. Il barone aveva già imboccato una strada precisa e suggeriva di creare anche una collezione di ceppi “negativi”, cioè di innestare il Solonis, il York-Madeira e qualche altro vitigno americano su ceppi tra i più robusti di quelli indigeni.
A fine novembre 1883, la Società di Acclimazione palermitana deliberava di impiantare nel proprio giardino sperimentale un vivaio di viti americane e contemporaneamente di istituire una scuola pratica di innesto, per accelerare il processo di ricostituzione dei vigneti su ceppi resistenti. Ancora una volta, Mendola si rese parte attiva facendo dono alla Società di un gruppo di 36 varietà, con relativa nota descrittiva.
Due anni dopo, finalmente, il Governo deliberava di istituire tre campi sperimentali, due dei quali in provincia di Messina e uno in Calabria, sotto l’unica direzione del professor Leobaldo Danesi, direttore della Stazione Agraria di Palermo. Intanto, nel piantonaio governativo creato nel capoluogo siciliano a Villa Camastra, erano già disponibili 30 mila viti americane di Riparia, così come nelle terre del viticoltore De Grazia, a Messina.
Sul finire degli anni Ottanta dell’800, la virulenza del parassita fillosserico non risparmiò neppure la preziosa collezione di vigneti del Mendola e solo la metà delle migliaia di esemplari «poterono salvarsi, inviandoli al Professor Segapeli di Catania, che poté innestarli nel vigneto della Regia Scuola di Viticoltura ed Enologia» [8].
Dal 20 al 26 maggio del 1888 si svolse a Palermo il 1° Congresso antifillosserico siciliano, La lunga tornata congressuale valse a fare il punto della situazione in ogni suo aspetto e a votare un ordine del giorno per chiedere al Governo di abbandonare «l’inutile sistema della distruzione» ed un altro presentato dal barone Mendola e dall’agronomo Alberti con il quale si chiedeva: «Che il vivaio di viti americane, oltre a offrire soggetti resistenti ottenuti per talee, [producesse anche] individui innestati belli e fatti e per opera di tecnici delegati all’uopo» [9]. Il congresso, alla presenza di numerosi viticoltori rappresentò la prima grande occasione per acquisire informazioni aggiornate e utili sull’utilizzo di viti americane, come quelle rese dal viticultore messinese, Giuseppe De Grazia.
Lʼaltro grande protagonista assoluto della rinascita del vigneto siciliano su piede americano fu senzʼaltro Federico Paulsen, nato a Roma nel 1861; laureatosi alla Scuola Agraria di Portici, si trasferì a Palermo nel 1885 a seguito della nomina ad assistente ai vivai di viti americane, pienamente operativo e scientificamente prolifico fino al 1937, anno del suo definitivo ritorno a Roma. Della folta schiera dei cosiddetti “americanisti” – tra i quali Antonio Ruggeri, Clemente Grimaldi, Corrado Montoneri, Vincenzo Prosperi, Giuseppe Ceccarelli, Angelo Longo, Domizio Cavazza, e Alberto Pirovano – Paulsen veniva considerato il capofila.
La questione dell’adattabilità delle viti americane rappresentava lo snodo principale della strategia di ricostituzione dei vigneti, in quanto non si trattava di scegliere la più resistente al parassita tra la moltitudine di varietà, bensì quella e solo quella che risultasse miglior portainnesti. E Paulsen si sforzava di far comprendere ai proprietari di vigneti che dovere attendere anche 4 anni prima di essere certi di aver trovato il portainnesti compatibile con il proprio terreno non avrebbe dovuto né stupire, né scoraggiare.
Una delle prime esperienze da lui condotte fu quella di studiare le affinità che potevano esistere fra i principali vitigni americani e le diverse varietà di Vitis vinifera, coltivate nell’agro palermitano e, a tale scopo,
«[…] tentai gli innesti di Perricone, Inzolia, Cataratto, Catanese, Nireddo, Zibibbo su Riparia, Yorck, Taylor, Clinton, Solonis, eseguendo gli innesti su talee, a tavolino, a spacco inglese, usando il coltello Kund. Da molti studiosi di questa materia è stato discusso se sia più vantaggioso innestare sul posto, ovvero di fare l’innesto a tavolino, e mettere quindi le talee innestate a vivaio per trapiantarle poi nell’anno seguente. […] io sono portato, in queste regioni, a consigliare sempre di dare la preferenza al piantamento diretto delle viti americane e all’innesto sul posto» [10].
Il Ministero di Agricoltura, fin dal 1888, aveva chiesto a Paulsen di occuparsi anche di ibridazione delle viti americane e Paulsen, allo scopo di ottenere un buon portainnesti per i terreni calcarei, iniziò a programmare sia gli accoppiamenti tra Berlandieri, Cinerea e Cordifolia con vitigni Rupestris e Riparia, sia di vitigni nostrali con Aestivalis e Rupestris.
Il 1° luglio del 1896, Paulsen fu nominato direttore di ruolo del “Vivaio Governativo di Viti Americane di Palermo” e, nell’agosto dell’anno successivo, direttore tecnico della “Associazione per lo sviluppo ricostituzione e miglioramento dei vigneti siciliani”, costituitasi per iniziativa di quella élite aristocratico-borghese, ancora influente a Palermo, composta da Giuseppe Lanza, conte di Mazzarino, Pietro Ballestreros, marchese di Bongiordano, Ignazio Florio jr., Giosuè Whitaker, il mazarese Vito Favara Scurto, Girolamo Settimo, principe di Fitalia, Giuseppe Artale, marchese di Collalto, l’agronomo Antonino Romano, Domenico Sommariva e Paolo Guerra.
Nel barbatellaio di Santa Flavia, da lui diretto con lʼassistente Nereo Maggioni, «gli innesti su talee di Berlandieri innestate con marze di Catarratto furono piantati dal 20 al 30 novembre 1897, e contemporaneamente furono piantate anche le talee di Berlandieri» [11].
Nella tenuta del principe di Butera, a Bagheria, si sperimentava, invece, la resistenza degli ibridi ottenuti a Palermo dallo stesso Paulsen. E nel territorio di Marsala, nel 1898, appena la fillossera venne rilevata, si costituì il “Consorzio Antifillosserico fra i Viticoltori marsalesi”, presieduto dal professor Ferdinando Vallese. Accanto a queste iniziative avviate da organismi di natura pubblica o da consorzi, si svilupparono anche quelle di singoli proprietari.
Nel 1899, Enrico Alliata duca di Salaparuta si rivolse al più importante vivaista privato dell’Isola che si trovava a Milazzo, e cioè Giuseppe Zirilli Lucifero, per lʼacquisto di 15 mila barbatelle di vite americana da fare innestare con le varietà indigene richieste:
«Io vi fornirò – scriveva Zirilli il 30 dicembre 1900 – la quantità di barbatelle di Rupestris du lot che vi saranno necessarie, che voi farete piantare secondo le mie indicazioni e io m’impegno ad innestarvele, nel modo e nel tempo che crederò più opportuni, a mie spese, rischi e pericoli, dovendovele consegnare innestate e vegetanti a fine luglio p.v. […] È stabilito che fornirete agli operai che potrò mandar sul luogo l’alloggio coi relativi letti. Il vitigno nostrano che dovrò innestare sarà il catarratto bianco e non altro, e voi sarete tenuto ad apprestarmi le marze che mi saranno necessarie, sia legnose, sia erbacee secondo quanto le richiederò. Ove il terreno nel quale sarà piantata la vigna fosse irrigabile ed entrambi noi fossimo di accordo d’irrigare, le irrigazioni dovranno esser fatte quando e come io ordinerò, ben s’intende a vs. spese, non dovendo io, oltre la fornitura delle barbatelle, sostenere altra spesa che quella dell’innestatura» [12].
Le raccomandazioni, i consigli, il dettaglio dei rispettivi impegni formalizzati lettera dopo lettera, delineavano un rapporto non di mera compravendita di piantine e di assistenza per gli innesti, bensì una vera e propria direzione colturale a distanza da parte dello Zirilli, il quale forniva indicazioni utili a correggere i metodi in uso nell’agro palermitano, al fine di far rinascere il vigneto che la fillossera aveva compromesso:
«Lo scasso a 50 cm – precisava il 3 gennaio – è assolutamente insufficiente. È invero peccato che nella vs. provincia, dopo che si spende tanto per ricostituire, sia invalso l’uso di meschinissimi scassi per non spendere un po’ dippiù! Credetemi non è un’economia; tutt’altro anzi! Io vi consiglio di arrivare ad un metro, per come molti lo abbiamo fatto qui in terreni anche duri come il metallo. Ma se a tale profondità non volete andare, spingetevi almeno a 85 centimetri; e ritenete che più profondamente scassate più economizzate. Finito lo scasso ed appianata la terra farete assestare la vigna con le canne e mi avviserete. Occorre però fare molta attenzione:
1° che i magliuoli siano perfettamente asciutti quando si conservano;
2° che la sabbia sia assolutamente asciutta, proprio secca, e se in quest’epoca è difficile farla seccare al sole, la si fa seccare in un forno. Purché la s’impieghi quando è ben raffreddata» [13].
La varietà ampelografica Catarratto era dominante da secoli, soprattutto nei vigneti della provincia di Trapani, ma non in quella di Palermo dove prevalevano Calabrese, Latina comune, Mantonico, Muscatello, Guarnaccia, e neppure in Sicilia orientale. La decisione quindi di impiantare nell’ex feudo del duca Enrico un tipo diverso di vite rispondeva evidentemente a un nuovo orientamento enologico che si intendeva adottare. Ciò, però, comportava dei problemi non indifferenti che lo Zirilli, con avvedutezza, segnalava in una lettera successiva:
«Poichè il catarratto a Casteldaccia è quasi sconosciuto e poiché nel predetto caso io dovrò innestare le barbatelle in erbaceo, come farete voi a fornirmi a suo tempo le marze erbacee non avendo vigne di catarratto dalle quali tagliarle?» [14].
Le obiezioni di Zirilli erano più che ragionevoli e, infatti, il duca Enrico convenne sulla soluzione di acquistare i magliuoli di Catarratto a Partinico e di attendere l’arrivo di un operaio di fiducia dello Zirilli per istruire i viticoltori locali:
«Or siccome intendo non risparmiar nulla perché la vs. vigna riesca il meglio che sia possibile è mia intenzione mandare al momento del piantamento un giovane operaio di mia fiducia da qui il quale farà vedere al vs capo operaio come desidero che le barbatelle siano piantate e, iniziato il lavoro, dopo un paio di giorni se ne tornerà»[15].
Il giovane Antonino Anania, «fra i migliori giovani operai di cui io disponga», precisava Zirilli, fu effettivamente inviato a Casteldaccia a metà del mese di marzo con le casse di barbatelle di vite americana. A fine maggio del 1901, lo stesso operaio tornava a Casteldaccia per l’avvio delle operazioni di innesto delle marze di Catarratto, svolgendo allo stesso tempo attività di istruzione nei confronti dei lavoranti del duca. Inoltre, se necessario, lo Zirilli si dichiarava pronto ad inviare altri cinque innestatori da Milazzo, per completare le operazioni in un paio di settimane. Nel successivo mese di luglio sarebbe stato sul campo ancora Anania, «per sciogliere gl’innesti».
La scelta del duca di sviluppare due vitigni classici dell’area occidentale della Sicilia rappresenta un dato interessante: vitigni pressoché ignorati nel palermitano cominciarono a essere coltivati dal duca Enrico nei primi anni del 900; 6.000 innesti di Catarratto e Inzolia vennero impiantati su piede americano di Rupestris Monticola.
Nelle tenute del duca di Salaparuta, – scriveva una fonte giornalistica nel 1905 – i vitigni Inzolia, Catarratto, Sauvignon de Sauternes «sono tutti già ricostituiti su ceppi americani, e ci fa piacere vedere un appezzamento di vigna innestato personalmente dal Duca Enrico, che volle personalmente dirigere la ricostituzione dei vigneti distrutti dall’invasione fillosserica. […] Tra le molte varietà emerge una specie di vite creata dal Duca Enrico a mezzo d’ibridazioni, ed è veramente splendida per la gran quantità di grappoli che porta unitamente ad una fertilissima vegetazione» [16].
Nel 1933, l’infaticabile ultrasettantenne Paulsen compilava una relazione sull’andamento dei vigneti sperimentali il cui contenuto spiega meglio di qualunque indagine biografica la qualità e serietà scientifica del suo operato:
«Le numerose ibridazioni eseguite in successivi anni nel Vivaio di Viti Americane di Palermo e che ammontano a più di una decina di migliaia, sono state prima, come ebbi occasione di dire in altre mie relazioni, passate in esame in terreni eminentemente fillosserati. Quivi sono state sottoposte a ripetute fillosserazioni, in modo da accertare la loro più o meno resistenza alla fillossera. Malgrado la maggior parte delle ibridazioni derivassero da incroci di varietà americane con altre americane, pur tuttavia la prova della resistenza alla fillossera ha fatto scartare inesorabilmente un gran numero di ibridi creati» [17].
Individuati i pochi più resistenti, si procedeva alla seconda selezione, impiantandoli in terreni calcarei (quelli prevalenti in Sicilia) per valutarne l’adattamento; infine, gli ibridi americani superstiti venivano innestati con i diversi vitigni locali:
«Gli ibridi che avevano vittoriosamente superato queste prove sono stati da me in seguito distribuiti in molteplici vigneti sperimentali, sparsi nell’isola e rappresentanti le più svariate condizioni di terreno e di clima, per meglio fissare l’area di adattamento, continuando annualmente a raccogliere le osservazioni sulla resistenza alla fillossera, l’adattamento al terreno e l’affinità coi vitigni locali» [18].
La scelta “americanista” si sarebbe rivelata l’unica realmente efficace, pur se avrebbe richiesto anni di sperimentazioni e di verifiche. La diffusione della fillossera segnò una svolta epocale nella storia della viticoltura europea, non solo siciliana ed ebbe ripercussioni gravi sia sul piano agronomico, sia su quello economico e sociale, a danno di larghi strati della popolazione rurale. L’avanzata implacabile dell’afide travolse l’azione di prevenzione delle autorità pubbliche, le ipotesi iniziali della comunità scientifica sulla biologia del parassita e i rimedi per sconfiggerlo. Ma grazie a questo nutrito esercito di agronomi e di intelligenti e appassionati vignaioli la viticoltura siciliana tornò a rivivere.